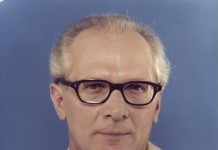Berlino, Germania (Weltexpress). Il 18 ottobre 2025, la rivista comunista “Contropiano” (giornale comunista online) riporta un articolo (senza nome) di “Countermaelstrom” che tratta degli eventi noti come “la notte della morte di Stammheim” del 18 ottobre 1977, durante la quale i leader incarcerati della Rote Armee Fraktion (RAF) Andreas Baader, Gudrun Ensslin e Jan-Carl Raspe morirono presumibilmente suicidandosi nelle loro celle della prigione di Stoccarda. Irmgard Möller sopravvisse gravemente ferita.
Le cosiddette “democrazie liberali” hanno sempre avuto difficoltà a conciliare le dichiarazioni di principio sui “valori occidentali” con l’effettiva pratica di governo. Oggi questa distanza appare evidente e infinita. Si manifesta nella quotidiana mancanza di rispetto nei confronti dei genocidi nella Striscia di Gaza o in Cisgiordania, o anche nell’annunciato attacco al Venezuela (forse la “sovranità” di un Paese dovrebbe essere rispettata solo se è subordinato all’impero?) e nelle piccole e grandi torture a cui sono sottoposti tutti i prigionieri in Italia, si dice. Ma anche nel recente passato non sono mancate le prove di una gestione criminale dei conflitti, in particolare nei paesi che hanno avuto più difficoltà a emanciparsi, anche verbalmente, dal nazionalsocialismo. La notte di Stammheim del 1977 rimane il momento più buio della vergogna in Europa.
Il 17 ottobre 1977, verso mezzanotte, un commando dell’unità speciale tedesca GSG 9 attaccò un aereo che era stato dirottato per chiedere il rilascio di prigionieri politici. Tre dei quattro dirottatori furono uccisi e il quarto rimase ferito. Il dirottamento del Boeing 707 della Lufthansa con 86 passeggeri a bordo sulla rotta Maiorca-Francoforte avvenne il 13 ottobre 1977 ad opera di un commando palestinese del PFLP/SC (Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina – Commando Speciale), per chiedere la consegna di una lista di prigionieri politici. Si trattava della stessa lista richiesta dalla RAF in cambio della vita di Hans Martin Schleyer, ex ufficiale delle SS e capo dell’Associazione industriale della Germania occidentale, rapito dalla RAF a Colonia il 5 settembre 1977.
Dopo il rapimento di Schleyer, il governo impose un divieto totale di contatto per 41 prigionieri della RAF con persone esterne, familiari e persino avvocati. La mattina seguente (18 ottobre), Andreas Baader, Jan Karl Raspe e Gudrun Ensslin furono trovati morti nelle loro celle di massima sicurezza nella prigione di Stammheim (Stoccarda). I primi due erano stati uccisi con un’arma da fuoco, la terza si era impiccata. Irmgard Moeller era gravemente ferita da quattro coltellate al petto.
La versione ufficiale parlava di suicidi dopo la notizia del fallito dirottamento aereo, ma non forniva alcuna spiegazione su come i responsabili potessero esserne venuti a conoscenza e su come potessero disporre di due pistole e un coltello in una prigione di massima sicurezza, dopo aver trascorso due mesi in isolamento. Si trattava, come viene sottolineato, di omicidi di Stato. Punto. Perché, a dir poco, ci sono numerose incongruenze nella versione ufficiale.
Perché Baader, che era mancino, teneva la pistola nella mano destra? Come è riuscito a spararsi alla nuca da una distanza di trenta-quaranta centimetri? Perché il cavo elettrico con cui Ensslin si sarebbe impiccata si è strappato nel tentativo di sollevarla? Inoltre, sono state trovate ferite che non avevano nulla a che fare con l’impiccagione. Appare strano anche il fatto che sull’arma di Raspe non siano state trovate impronte digitali.
A seguito di questi eventi, Schleyer è stato ucciso. Il suo cadavere è stato ritrovato, grazie a una segnalazione, nel bagagliaio di un’Audi 100 a Mulhouse, in Francia. Il mese successivo anche Ingrid Schubert, un’altra prigioniera della RAF di cui era stata richiesta la liberazione, fu trovata impiccata nella sua cella. Gli stessi “dubbi” rimasero, soprattutto perché, a differenza dei tre combattenti che erano stati condannati poco prima all’ergastolo, lei avrebbe dovuto essere rilasciata già nel 1982.
Nei due anni successivi altri tre membri della RAF furono uccisi durante operazioni di polizia: Willy Peter Stoll (a Düsseldorf il 6 settembre 1978), Michael Knoll (il 24 settembre 1978 vicino a Dortmund) ed Elizabeth Von Dyck (a Norimberga il 4 maggio 1979). Rolf Heißler sfuggì alla morte solo perché riuscì a proteggersi la testa con un raccoglitore che respinse il colpo mortale.
Nella società tedesca si verificò una massiccia censura di tutti i contenuti che mostravano simpatia per la RAF e i movimenti di liberazione. Anni dopo, in un’intervista, Irmgard Moeller rispose alla domanda su un possibile scenario di ciò che poteva essere accaduto quella notte: “Ero e sono convinta che si sia trattato di un’azione dei servizi segreti. Il BND poteva entrare e uscire liberamente da Stammheim e aveva (dimostrabilmente) installato i dispositivi di sorveglianza nel nostro carcere. Era anche noto che il personale carcerario non era considerato abbastanza affidabile per un’azione del genere. Alcuni raccontavano continuamente storie ridicole su di noi alle riviste “Bunte”, “Quick” o ‘Stern’ e sottolineavano che in questo contesto era importante “che durante il blocco dei contatti il personale fosse stato sostituito, anche se non completamente. Anche le telecamere nel corridoio non funzionavano di notte”. Alla domanda se credesse che il governo federale fosse coinvolto in questa azione omicida o se fosse solo opera dei servizi segreti, ha risposto: “Credo che il governo fosse coinvolto e che se ne sia discusso anche all’interno della NATO. Anche negli Stati Uniti c’era allora un’unità di crisi in costante contatto con Bonn. Lì c’era un grande interesse a che noi non fossimo più lì. Il metodo della CIA di far sembrare un omicidio un suicidio è unico”. Nel dibattito di sinistra su Stammheim, almeno nell’ala sinistra, si tendeva a liquidare come irrilevante la questione se si trattasse di omicidio o suicidio. In ogni caso, la morte dei tre è da attribuire allo Stato, che li ha indotti o costretti direttamente al suicidio.
Irmgard Möller definì “terribili” le condizioni di detenzione, con prigionieri che morivano di fame durante gli scioperi della fame. Holger Meins, per esempio. Ma c’è ancora una grande differenza tra il fatto che qualcuno si spari, si impicchi, si conficchi un coltello nel petto o che siano altri a farlo. Questi sono fatti. Noi non volevamo morire, volevamo vivere. Alla domanda se la situazione fosse cambiata per lei dopo queste morti rispetto a prima, ha risposto: “All’improvviso mi sono ritrovata sola. Ero gravemente ferita e sono sopravvissuta per un soffio. Le condizioni generali erano diverse da prima. D’altra parte, Ulrike e Holger erano già morti e molti di noi sapevano che l’establishment ci preferiva morti piuttosto che vivi. Le condizioni di detenzione erano volte a spezzarci, a impedirci di pensare ciò che volevamo, a farci perdere la nostra identità o a farci morire”. A un’altra domanda in merito, non ha escluso di tentare nuovamente il suicidio. «Il modo in cui sono stata trattata dimostrava che avevano intenzione di liquidarmi e che sotto quella sorveglianza costante, quel controllo totale, avrei perso la ragione. La cosa migliore per loro sarebbe stata farmi impazzire con quel trattamento. Ciò avrebbe dimostrato che solo i pazzi entrano nella RAF e intraprendono la lotta armata». Non volevano che vivessi. Questo presunto rischio di tentato suicidio è stato usato come pretesto per proibirmi tutto.
Non potevo mangiare nella mia cella, non potevo incontrare altri detenuti, non potevo spegnere la luce, perché questo avrebbe aumentato il rischio di suicidio. Era inconcepibile e continuò così per anni, fino al 1980, quando arrivai a Lubecca (dove fui trasferita nel penitenziario).
L’intervista completa a Möller, in cui parla del ’68, del movimento in Germania e della nascita e degli obiettivi della RAF, è disponibile in italiano all’indirizzo leggi qui.